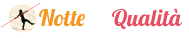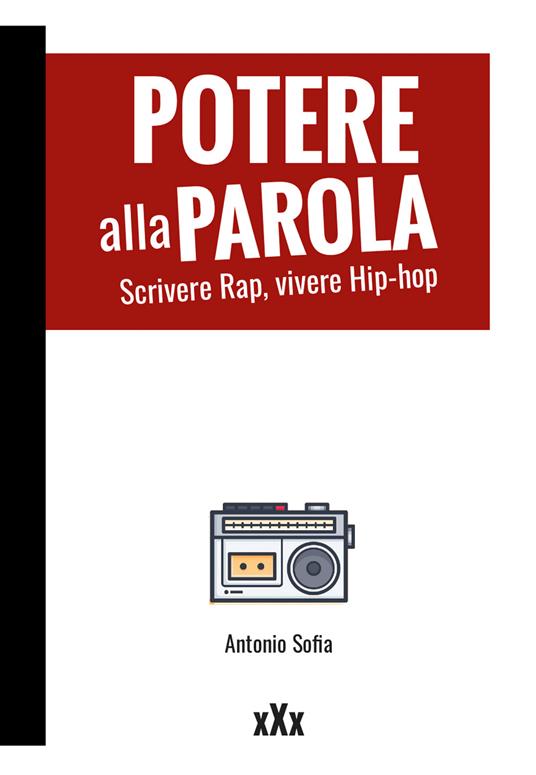
27 Mar Approfondimenti stupefacenti: “Potere alla parola. Scrivere rap, vivere hip hop”, intervista ad Antonio Sofia
Presenti nel presente
Esperienze educative e cultura hip hop
“Parole a volte profonde e a volte triviali, a volte poetiche e a volte oscene, a volte ponderate e a volte istintive (…) parole da poeti e da stronzi, da criminali e da intellettuali, da puttanieri e rivoluzionari. Parole che nel loro complesso, fanno del rap ciò che è.” Cesare Alemanni
Abbiamo fatto quattro chiacchiere con Antonio Sofia, scrittore e ricercatore pugliese che ha pubblicato di recente il libro Potere alla parola. Scrivere rap, vivere Hip Hop per Momo Edizioni.
Saggio recentissimo e fondamentale per lo sviluppo della ricerca sulla cultura hip hop da una prospettiva pedagogica. Si parte dalla scuola attiva dei coniugi Freinet, si passa per la pedagogia popolare di Mario Lodi e dal proto rap dei Last Poets, si incontra la grammatica della fantasia di Gianni Rodari e il linguaggio sguaiato della trap, si nuota fino alla riga con Elisabeth Bing, si parla di Rap game e pedagogia hip hop, di barre e slang, di musica liquida e di elogio del margine. Il saggio nella prima parte affronta attraverso interviste ad operatori, educatori e artisti la proposta educativa con l’hip hop nelle scuole, nelle carceri e nelle associazioni (ci siamo anche noi della Cooperativa CAT!); la seconda parte invece raccoglie le testimonianze di alcuni tra i protagonisti della scena hip hop italiana e della sua evoluzione (Danno, Frankie Hi-nrg, Tormento, Militant A, ecc).
La prima domanda che ti faccio è anche quella che ricorre spesso nel libro e che poni a quasi tutti i tuoi interlocutori: quando hai incontrato l’hip hop e quando hai capito che col rap si poteva fare la rivoluzione?
Anche se non sono mai stato in una crew, il rap me lo porto dietro da quando, al primo anno di Università in quel di Bari, sono diventato amico di un b-boy che mi fece ascoltare Colle der Fomento, Piotta, Caparezza, ecc. Nei primi anni Duemila con alcuni amici abbiamo fatto ricerca nel soul e nel funky anni ‘60 e ‘70, dunque alle origini del rap americano e grazie alla facilità con cui in quel periodo si scaricava la musica dalla rete ho ascoltato intere discografie.
Durante il periodo pandemico ho dovuto ridefinire il mio lavoro di ricerca per l’impossibilità di muovermi e ho iniziato a ragionare se ci potesse essere una coniugazione tra pedagogia e hip hop; così ho scoperto il libro di Davide Fant intitolato appunto Pedagogia Hip Hop, ho contattato Fabrizio Bruno di 232 APS e sono riuscito a legare questa mia passione con il lavoro da ricercatore.
Credo che il libro di Fant sia il testo che finalmente mette nero su bianco qualcosa che era nell’aria già da moltissimo tempo; tu parti da Mario Lodi e dall’educazione popolare di Frenet, trovando analogie anche col pensiero gramsciano quando parla di legame indissolubile tra responsabilità sociali e pedagogiche (“cambiare la società per cambiare la scuola”), secondo te c’era già un humus culturale in cui l’hip hop si è potuto diffondere?
Dal punto di vista pedagogico c’era un humus comune ai miei riferimenti di studio, dalla pedagogia popolare di Freinet al Movimento di Cooperazione Educativa (MCE) di Bruno Ciari e quello che io pensavo si potesse realizzare con i laboratori di hip hop proprio perché la pedagogia popolare nasce dal riconoscimento come soggetto della bambina e del bambino e all’attribuzione di valore al loro pensiero. Nei libri di Mario Lodi la giornata scolastica iniziava col racconto di quello che i bambini e le bambine avevano visto mentre arrivavano a scuola, il racconto del mondo che c’è intorno alla scuola, il mondo che attraversano. L’Hip Hop nasce da un iniziale momento di festa, ma diventa presto lo strumento per raccontare lo spazio che si ha intorno e soprattutto per trasformarlo. Partito dalle macerie del Bronx e quindi da una situazione di indigenza e marginalità oggi dopo 50 anni abbiamo un fenomeno culturale che condiziona non solo il mercato della musica ma anche gran parte della moda, del cinema e della comunicazione.
Quindi in primo luogo all’origine c’è il riconoscimento reciproco, cioè riuscire a stabilire relazioni non violente in un territorio martoriato dalla crisi socio-economica e politica (il Bronx), un contesto in cui i neri e i latini erano fantasmi irrilevanti per gli interessi di New York, disperati e senza futuro, nella guerra tra gang e per l’abuso di sostanze. Se ci pensiamo non è molto diverso dalle difficoltà che si verificano in un contesto educativo dove l’adulto non riconosce chi ha davanti come un soggetto portatore di un patrimonio di impressioni, pensieri, emozioni e considerazioni critiche.
In secondo luogo interviene la valorizzazione di quello che si ha: l’hip hop nasce da ciò che si ha a disposizione, eleva le risorse che ciascuno già possiede, introducendo la possibilità individuale e collettiva di trasformare la realtà. Ecco, questi per me sono principi pedagogici fondamentali che ritrovo nella cultura hip hop.
Quale è stata la criticità più diffusa che hai riscontrato nelle interviste agli operatori e quale la soddisfazione più grande?
La criticità comune più diffusa è la precarietà e la scarsa sostenibilità dei progetti educativi: spesso sono percorsi attivati con finanziamenti limitati. Le relazioni educative hanno bisogno di continuità nel tempo e di spazi dedicati per diventare significative, la precarietà e l’estemporaneità dei finanziamenti compromettono il raggiungimento di approcci strutturali integrati nel tessuto urbano. Al contrario, sono convinto che l’educazione sia una risorsa di inestimabile potenziale, di cui si gioverebbe tutta la comunità.
La soddisfazione più grande invece è stata quella di raccogliere le testimonianze di chi sa trovare e far emergere bellezza, ironia, autonomia, riflessione in luoghi dove si perde la speranza che queste cose ci siano. A volte c’è una sottovalutazione e una sottostima del pensiero critico dei ragazzi e delle ragazze che vengono privati di spazi di espressione, dando per scontato che gli adolescenti non abbiano niente da dire semplicemente perché non lo dicono. Molto probabilmente non hanno spazi sicuri dove esprimersi e soprattutto nessuno che li ascolta; dal momento che l’adolescente è in un contesto sicuro, può farsi portatore di pensiero critico di cui noi abbiamo bisogno per sperare in un futuro diverso dal presente che noi adulti gli abbiamo messo davanti.
Andiamo appunto sul presente: la Trap è una delle musiche più ascoltate tra i post millennials e il Drill ormai è mainstream, come si collocano questi due ormai ex sottogeneri del rap all’interno dei laboratori hip hop? Si tratta di un continuum, una sorta di upgrade?
Il Drill non lo cito perché, ai tempi della redazione del libro non era ancora esploso come adesso. Comunque credo possa valere lo stesso discorso che faccio per la Trap: entrambi sono stili, sottogeneri importanti all’interno di laboratori perché rispetto al rap richiedono minori competenze linguistiche. Il rap ricerca rime, assonanze, allitterazioni, consonanze che necessitano una conoscenza della lingua piuttosto forte; la trap e la drill sono meno esigenti da questo punto di vista, quindi si può lavorare con adolescenti che hanno fragilità nel padroneggiare la lingua italiana (magari è la seconda lingua perché figli o figlie di immigrati); altro aspetto interessante è che nella trap, più che nel drill, si può giocare con il flow su linee melodiche, anche attraverso un uso consapevole dell’autotune.
Vi aspettiamo carichissim* il 30 Marzo alle ore 18, al Centro Java!